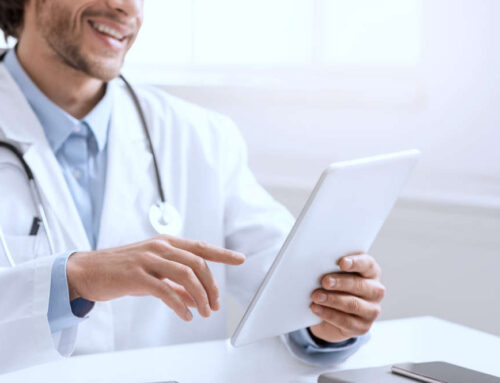I processi fisici, metabolici e psicologici inerenti allo sviluppo rivelano che i bambini non possono essere considerati piccoli adulti e non possono neanche essere considerati un gruppo omogeneo in sé. È pertanto necessario che siano sviluppati farmaci su misura e che l’attività di farmacovigilanza in pediatria sia più mirata. Ecco cosa ha riportato Laura Boga, QPPV presso Dompè Pharmaceutical, durante il suo intervento sui pazienti pediatrici all’European Pharmacovigilance Congress 2019.
I pazienti pediatrici
Si identificano come pazienti pediatrici gli individui compresi nella fascia d’età da 0 a 18 anni. Tale categoria rientra nelle cosiddette special population, ovvero categorie di pazienti potenzialmente più fragili per via delle loro caratteristiche. I pazienti pediatrici sono infatti caratterizzati da cambiamenti nella fisiologia durante la crescita, da diversi parametri farmacodinamici e farmacocinetici rispetto agli adulti, da immaturità di alcuni sistemi di organi, da cambiamenti nella massa corporea e nella composizione e da maggiore sensibilità agli eccipienti farmacologicamente attivi. Tutto ciò fa sì che i pazienti pediatrici abbiano reazioni differenti rispetto agli adulti.
Gli studi clinici in pediatria
Ogni farmaco per ottenere l’Autorizzazione all’immissione in commercio deve essere sottoposto a studi approfonditi, inclusi test preclinici e sperimentazioni cliniche al fine di garantirne sicurezza, efficacia e qualità. Spesso però la popolazione pediatrica non rientra in tali studi. Ciò che ne consegue è una limitata disponibilità di farmaci adatti ai più piccoli a cui vengono pertanto somministrati medicinali rivolti a pazienti adulti. La farmacovigilanza in pediatria risulta pertanto un valido aiuto per il miglioramento del profilo di sicurezza di un farmaco.
Potrebbe interessarti anche: Farmacovigilanza cos’è e a cosa serve
Regolamento pediatrico
A gennaio 2007 è entrato in vigore il Regolamento (EC) 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sui medicinali per uso pediatrico, modificando il regolamento (CEE) 1768/92, la direttiva 2001/20/CE e il regolamento (CE) 726/2004.
L’obiettivo del Regolamento Pediatrico è l’ottimizzazione della salute pediatrica nell’Unione europea. A tale scopo s’intende facilitare lo sviluppo e la disponibilità di medicinali per bambini, garantire la qualità dei farmaci sottoponendoli a ricerca etica e autorizzandoli in modo appropriato e migliorare la disponibilità di informazioni sull’uso di medicinali per bambini. Tutto ciò nel rispetto della salute dei pazienti cercando il più possibile di evitare ai bambini test superflui e senza ritardare l’autorizzazione di medicinali per l’uso negli adulti.
Linee guida per la farmacovigilanza in pediatria
A novembre 2018 sono entrate in vigore le GVP (Guideline on Good Pharmacovigilance Practises) relative alla pediatria (GVP – Product – or population – Specific Consideration IV: Paediatric Population).
Li linee guida trattano principalmente temi riguardanti medicinali con indicazione pediatrica, con indicazione per adulti e sviluppo pediatrico in corso e con indicazione per adulti, per i quali esiste evidenza di utilizzo nella popolazione pediatrica. Non tratta invece temi di vaccini e la sorveglianza della sicurezza degli esiti pediatrici dopo l’esposizione a farmaci in utero.
Potrebbe interessarti anche: Farmacovigilanza in gravidanza
Il ruolo di EMA nella farmacovigilanza pediatrica
Nel 2007 è stato istituito presso EMA il PDCO (Paediatric Committee). Si tratta di un comitato scientifico multidisciplinare responsabile principalmente della valutazione e dell’approvazione dei Piani di Investigazione Pediatrica (PIP).
Il PDCO interagisce con altri comitati, in particolare il CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use), il PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) e il COMP (Committee for Orphan Medicinal Products) su qualsiasi questione relativa allo sviluppo di medicinali per uso pediatrico.
Le responsabilità del PDCO includono anche le domande di esenzione totale o parziale dal PIP e per lo studio rinvii.
Il PDCO e il PRAC interagiscono sulla promozione dello sviluppo precoce delle strategie di gestione del rischio, comprendendo l’impatto dei problemi di sicurezza emergenti sullo sviluppo pediatrico, acquisendo informazioni sui bisogni pediatrici e garantendo in generale che le attività di farmacovigilanza siano adattate per affrontare le sfide specifiche della raccolta di misure di sicurezza dati nella popolazione pediatrica.
Rischio di eventi avversi in pazienti pediatrici
Il rischio di eventi avversi può potenzialmente aumentare in alcuni casi specifici.
Esposizione a lungo termine. La somministrazione di un determinato farmaco per un periodo troppo esteso può comportare effetti sul bambino. Per esempio può interferire sullo sviluppo di organi, sulla crescita scheletrica, sulla maturazione sessuale e sullo sviluppo neurocomportamentale. Tali effetti possono diventare evidenti, visibili o identificabili solo dopo diversi anni, addirittura anche solo in età adulta. È pertanto necessario eseguire follow-up a lungo termine per osservare gli effetti in più fasi dello sviluppo.
Utilizzo off label. La somministrazione di un farmaco non specifico per questa fascia d’età può esporre il paziente ad ulteriori rischi di eventi avversi o di inefficacia del trattamento. È pertanto necessario ampliare la gamma di farmaci ad uso pediatrico.
Errore farmaceutico. Un ulteriore potenziale rischio può avvenire in seguito a un fallimento involontario nel processo di trattamento farmacologico. Può verificarsi al momento della prescrizione, conservazione, erogazione, preparazione o somministrazione di un medicinale. A causa della disponibilità limitata di farmaci con indicazione pediatrica o forma farmaceutica appropriata, i bambini possono essere trattati a dosaggi dedotti da pazienti adulti o con forme farmaceutiche inadeguate.
Insufficienza di safety data. Gli studi clinici pediatrici sono limitati a un campione non sufficientemente elevato e per di più relativo a un periodo di tempo limitato. Ciò che ne consegue è una scarsa conoscenza dei reali rischi e pertanto una mancanza di consapevolezza nella somministrazione.
Erroneità o mancanza di presentazione clinica di ADR (Adverse Drug Reaction). La segnalazione della reazione avversa potrebbe essere incompleta, non specifica o mal interpretata. In alcuni casi addirittura la reazione potrebbe addirittura non venire riscontrata, e di conseguenza non segnalata. Questo accade in casi in cui si verificano sintomi abbastanza comuni nei bambini come vomito, diarrea, sonnolenza o pianto. Tali reazioni potrebbero essere sottostimate.
RMP (Risk Management Plan)
I metodi utilizzati per la minimizzazione del rischio di reazioni avverse nella popolazione adulta devono essere valutati e adattati ai pazienti pediatrici, tenendo conto di aspetti specifici:
- evidenza preclinica. I risultati degli studi tossicologici su animali giovanili possono avere un valore predittivo in termini di effetti nella popolazione pediatrica e possono supportare l’assegnazione di priorità alle domande di ricerca di farmacovigilanza;
- dati clinici. Questi dovrebbero supportare nell’identificazione di importanti rischi potenziali, nella caratterizzazione del profilo di sicurezza nonché nella descrizione degli strumenti per ridurre il rischio correlato all’uso del prodotto nella popolazione pediatrica;
- mancanza di dati clinici precedenti negli adulti. Qualora un medicinale sia stato autorizzato esclusivamente per pazienti pediatrici o contemporaneamente per pazienti adulti e pediatrici, c’è una mancanza di dati clinici e questo comporta una lacuna nel RMP.
Gestione della farmacovigilanza in pediatria: reportistica di ADR
Gli ICSR devono includere:
- informazioni precise sull’età con annotazione di giorno, mese ed anno oppure indicando il sottoinsieme di età pediatrica (Preterm New-born Neonates, Term and Post-term Neonates, Infants, Children, Adolescents);
- peso e altezza del paziente;
- principali parametri di sviluppo come prematurità, stadio di sviluppo puberale, sviluppo cognitivo o motorio;
- indicazione per l’uso, forma farmacologica e dose del farmaco.
Eventuali informazioni mancanti devono essere oggetto di follow up per garantire la qualità e integrità dei dati.
Potrebbe interessarti anche: Farmacovigilanza in geriatria
PSUR (Periodic Safety Update Report)
Il PSUR è uno strumento per il monitoraggio continuo del rapporto rischio-beneficio e l’analisi cumulativa delle informazioni sull’uso pediatrico. Gli argomenti che deve trattare sono:
- eventuale nuovo problema di sicurezza identificato nella popolazione pediatrica;
- utilizzo off-label, incluso l’uso di formulazioni non adatte all’età o l’uso in sottogruppi pediatrici per i quali il prodotto non è autorizzato;
- qualsiasi segnale identificato di una reazione avversa pediatrica;
- esposizione di pazienti pediatrici durante l’intervallo di segnalazione PSUR, segnalata per sottogruppi di età;
- risultati relativi alla sicurezza derivanti da studi clinici pediatrici in corso o completati, inclusi anche quelli previsti nel PIP (Piano d’Indagine Pediatrica).
- le fonti: studi clinici, uso post autorizzazione, segnalazione spontanea, letteratura.
PASS (Post-authorisation safety studies)
Per la pediatria, il PASS può essere di particolare valore quando si prevede che gli effetti sullo sviluppo possano manifestarsi solo anni dopo l’esposizione al farmaco, quando i dati sulla sicurezza a lungo termine sono necessari a causa dell’uso cronico o quando c’è stato un uso off-label ed è stato sospettato un problema di sicurezza.
Nel PASS è bene integrare i dati precedenti all’autorizzazione in commercio con quelli raccolti nella sorveglianza post marketing.
Signal detection
Per la Signal Detection è fondamentale distinguere e analizzare le diversità delle reazioni tra i pazienti pediatrici e quelli adulti ed entrare nel merito della sottocategoria di appartenenza, senza soffermarsi sulla fascia pediatrica in generale.
Difficoltà e migliorie
Nonostante i progressi fatti in questo ambito, grazie anche alle più recenti regolamentazioni e linee guida, continuano a persistere delle difficoltà per le attività di farmacovigilanza date per lo più dalla sottostima delle reazioni avverse sospette nei bambini, dai frequenti errori terapeutici e più gravi nella popolazione pediatrica e dalla difficoltà di dimostrare l’efficacia di minimizzazione del rischio dei nuovi medicinali a disposizione della popolazione pediatrica.
Un potenziale aiuto potrebbe essere dare maggiore consapevolezza ai pazienti pediatrici in grado di assumere in autonomia i farmaci attraverso comunicazione personalizzata tramite per esempio infografiche, fumetti e social media.
La misura più efficace rimane sicuramente lo sviluppo di sempre più farmaci appositamente formulati per questa specifica fascia d’età.